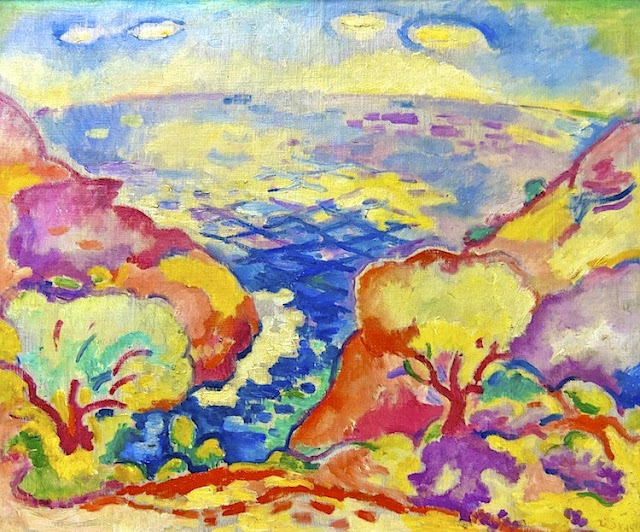Martedì 9 maggio 2017
ODRELE. Poche settimane, piange a
letto, solo. Mi avvicino, chiedo, do un’occhiata alla fiche: malaria, anemia, malnutrizione,
piaghe nella zona anale. Caso frequente, caso grave, nonostante sia arrivato in
ospedale e nonostante la trasfusione in corso, l’ho imparato anche io. Gli
porgo un dito e lui con la sua manina lo stringe forte, manina da pelle
sfinita, e smette di piangere. Poco dopo vedo arrivare la mamma, Aloko, non più
di 14 anni, con un viso da bambina e seni grossi da madre, occhi inesperti e
impauriti. Ingravidata da qualche ragazzo in un rah notturno del suo villaggio, Modusu, lasciata sola come una bambina
con la sua bambola.
Arriva anche la nonna, che avrà
la mia età, solcata dalla fame, e sul suo dorso un altro bambino: anche lui
soffre visibilmente di malnutrizione, lo dicono le occhiaie gonfie, quei ciuffi
di capelli ingialliti. Saluto e torno ai miei lavori.
Ripasso per caso dopo un paio di
ore: nella corsia la mamma si tiene la nuca con le mani, come un ragazzino in
panico; capisco e corro a chiamare un infermiere, ma è solo per constatare il
decesso.
ENEKU ODRELE, di 5 mesi, nato in
un giorno imprecisato di novembre e spentosi il 9 maggio, figlio di Odrele e
Aloko, cattolico, non è più. Non dorme, non dorme con quegli occhi bianchi che
non si chiudono, con quella bocca rigida e spalancata come a cercare un ultimo
respiro.
Justin, l’infermiere di turno,
incomincia a bendarlo con garze e pany e intanto canta, come se fosse l’ultima
ninna nanna per chi non ha conosciuto oltre la vita. È un canto sottovoce, un
canto inverosimilmente dolce e insieme struggente.
Rimane qui col corpo solo la
nonna, come per caso, guardandosi attorno, mentre la figlia è corsa fuori: la
rincontrerò a vagare fuori dal padiglione di chirurgia, con un’espressione
alienata e la riaccompagnerò mano nella mano. Storie di fame, di solitudini, di
disperazione senza voce.
Ma Dio si ricorderà di questo
nome, Odrele, o è già stato avvolto dal nulla?
Mercoledì 10 Maggio 2017
All’ospedale entra una nonna che
mi sorride e con la quale scambio allegramente due chiacchiere in lugbara, un
canto, due risate. È contenta, mi dice, perché ha raccolto dei manghi nella
brousse attorno e con questi riuscirà a trovare qualche soldo. Mi trovo appena
fuori dal cancello dell’ospedale con Benjamin e Michel, prendo il tempo di
qualche parola con loro.
Trenta secondi dopo la nonna
ritorna, sembra si diriga verso me, anzi cerca proprio me, ma con
un’espressione molto differente da poco prima: “mundele, akufi!” dice, e
capisco immediatamente anche io.
Ha lasciato i manghi a terra e
corre a casa ad avvisare il resto della famiglia, mentre la notte scende e
lacrime rigano fitte il suo volto, la voce è stravolta. Anche Monde è morto e vedo
che il suo letto è già occupato: ADRIKO TOTO, con una mamma appena tredicenne,
che mi sorride e spera, mentre è in corso la trasfusione di sangue, mentre il
ventre ondeggia disperato e gli occhi tremano all’indietro. Dice di avermi già
incontrato alla festa di Kamakà a Pasqua, io le sorrido e intanto mi chiedo “Dio
si dimenticherà di loro?” mi chiedo “Dio si dimenticherà anche di loro?”.
Ne guarisce uno e ne entrano altri
cinque.
È una mietitura di sangue e
innocenti.
È la strage di Erode a Betlemme.
E prima di chiudere gli occhi,
stasera, senza ben capire perché, mi appaiono le parole “Non uccidere” e ne
sento i brividi di terrore.
Venerdì 12 Maggio 2017
Stamattina Toto è morto.
È venuta la mamma stessa,
Bhileni, a dirmelo; è passata a cercarmi alla cassa e mi ha parlato con un
sorriso timido sul volto. È forse per questo che ho pensato di non aver ben
capito, ho chiesto conferma a Noella ma c’era troppo trambusto. Ieri avevo dato
loro qualche soldo per un pasto decente e ieri sera gli occhi di Toto mi riconoscevano,
quasi sorridevano: anche se non sapeva parlare, ne sono sicuro.
Il tempo di arrangiare ciò che sto
facendo e, arrivato in pediatria, lei è già partita col suo corpicino, il suo
posto è occupato da un altro.
Chiedo a Mireille: “Sì, il
bambino del primo letto è morto”, ma stavolta non ce l’ho fatta, ad avvicinarmi
al nuovo arrivato.
Silenzio. I pugni allo stomaco
fanno male anche quando te li aspetti.
Silenzio. Lo sapevi, Lele.
Silenzio.
Ne guarisce uno e ne entrano
altri cinque, mi ripeto chiudendo gli occhi, respirando l’aria calda e la
sabbia del cortile: torna a finire il tuo lavoro, Lele.
Ma io che posso fare? Io non
posso fare nulla, ma non per questo mi devo arrendere.
I poveri si prendono tutto,
talvolta anche quello che non avresti voluto dare. Anche il dolore.
Spesso ti riempiono di gioia,
altrettanto spesso ti fanno perdere ogni pazienza e tornare nero nella tua
stanza chiusa.
Alcuni sono riconoscenti, da
altri ti senti usato e acconsenti più o meno volentieri.
Certo è che i poveri non sono
migliori dei ricchi (come peraltro neanche viceversa): non sono più belli, più
gentili o più umili, più sinceri o più intelligenti, mai creduto, ma vivono del
nostro stesso cielo e soffrono, oppressi da un’ingiustizia muta ma violenta.
I poveri si prendono tutto,
talvolta anche quello che non avresti voluto dare, ma è giusto che sia così.
Sabato 13 maggio 2017
La verità, pensavo oggi, è che
siamo in guerra, e non da oggi.
Una guerra dell’indifferenza,
dell’arroganza e di un materialismo becero, cieco, animale. Una guerra contro
il dialogo, il pensiero attivo, contro la nostra spiritualità e ogni concetto
di verità. Mica una guerra retorica, una guerra di idee, poiché il sangue cola
e i deboli sono vittime: è una guerra assassina, se penso a miriadi di
situazioni dappertutto, dai paesi sottosviluppati, ai paesi del Medioriente,
dai disoccupati, dai disadattati delle nostre città alle baraccopoli indiane
c’è un sistema malato che toglie vita.
Lo dico senza dietrologie: è solo
il diluvio che perdura, la fine di un mondo. Lo scrivo senza demonizzare il
diverso, senza paura dell’altro, senza terrore del nuovo, senza invocare
rivoluzioni, ma solo una coscienza.
È un’evidenza che il mondo
dell’opulenza può reggersi solo grazie a un mondo parallelo di oppressi, che il
lusso insensato di qualcuno è l’altra faccia della medaglia di Odrele e di tanti,
troppi, altri. E questo sistema passa nell’indifferenza, nell’apatia, in
quell’accettazione impotente che non ricorda più cosa fosse “uomo”, di come la
parola “umanità” si possa declinare unicamente al plurale.
Qui i cittadini disprezzano
quelli che vengono dai centri provinciali, che disprezzano a loro volta chi
viene dai villaggi, che bollano con disprezzo chi viene dalla brousse: coloro
che sono in difficoltà preferiscono dare contro a coloro che sono ancora più
deboli, piuttosto che guardare in faccia ciò che li sta annientando, sembra una
legge universale. In Europa non avviene lo stesso? La situazione è complicata e
merita equilibrio, saggezza, ma spesso sembra che si possa risolvere tutto
accanendosi rabbiosamente contro immigrati, scappati dalla disperazione: come
se il problema principale, in uno stato in cui le riforme hanno dato il passo a
corruzione e mafie, uno stato privo di slancio culturale e di
imprenditorialità, sepolto da un’identità dimenticata e burocrazia, fossero
loro. Come se si potesse distruggere una cultura dall’esterno, e non fosse
invece già marcia interiormente.
La morte dei sogni è la fine del
mondo. Il diluvio.
Io, col mio carattere pessimo,
ingarbugliato e cocciuto, rancoroso e insicuro, con le mie unghie sempre
mangiucchiate e gli occhi bassi, so che le parole, i valori, i sogni sono
reali, sono validi solo se “incarnati”: non si inventano, non hanno bisogno di
difesa né si proclamano a vanvera, ma hanno vita nelle persone e nelle loro
scelte concrete, quotidiane, controcorrente. Verbum caro factum est, qualcuno scrisse. Dove sono finiti i nostri
sogni di fraternità, di giustizia? Li abbiamo rimessi in tasca? La verità è che
lo sappiamo, vediamo il diluvio che dilaga lentamente, ma preferiamo chiudere
gli occhi: ci accontentiamo di un pasto caldo e qualche passatempo, rigirandoci
in una perenne alienazione, in una continua lamentazione, ossessionati da
paure, tanto da non agire che per queste, senza più esserne protagonisti, della
nostra c…o di meravigliosa vita. Si segue un egoismo esasperato, si grida alla
libertà per poi perdere la propria autenticità in un mare magnum senza nome,
massa incolore, indifferente, mentre la stanchezza dell’abitudine ci ha
narcotizzato. Forse è solo una questione di comodità, il diluvio. La fine del
mondo, la fine di un mondo, il diluvio ecco: sostituire il sogno con la
sopravvivenza, con il terrore. Ciascuno salvi se stesso? No, ciascuno salvi la
propria piccola fiammella, ma la salvi all’altro,
verso l’altro, verso un mondo futuro,
rinnovato, migliore. “La mia vita è inserire vita dove c’è la morte”.
Nella testa ho ancora il nome di
Odrele. No, neppure Dio lo ha dimenticato, ne sono sicuro, e neppure il suo
volto, che io già confondo con quello di tanti altri: non lo dimenticherà e il
mondo stesso ne chiederà conto, di questo suo figlio. Il sogno di Dio non è
questo, il sogno dell’uomo era altro, era più alto, ma chi non si alza si
allinea. E io so, lo conosco attraverso questi miei nuovi compagni, che si può
insultare, oltraggiare, deturpare, violentare, uccidere, devastare la vita, la
si può persino annientare, ma la vita è più forte e rigermoglia, silenziosa e
ogni volta e per sempre: no, la vita non la si può sconfiggere. Neppure in
questa guerra.
Heritier, mi ha detto Suza, è guarito.
Ho finito, di scrivere, di
piangere, di gridare. Solo ora mi accorgo che la persona contro cui mi infuoco
tanto è il mio piccolo io.